La scrittrice Edith Bruck propone un romanzo di ispirazione autobiografica, incentrato sull’epopea esistenziale di una ragazza ebrea, e che principia in un cupo villaggio ungherese e finisce nella solatia Italia, attraversando tutto l’incubo novecentesco del popolo israeliano.
Inventio
Il Pane perduto è un libro blasfemo e vitale. Blasfemo, probabilmente, proprio perché vitale. La bestemmia, si sa, è legata al sentimento religioso, e nel nostro caso è quello ebraico. Ebbene, parlare del mondo ebraico senza fare riferimenti alla sua religione è già blasfemo, come lo è citare in continuazione il nome di dio, anzi, rivolgergli addirittura un apostrofe finale. Ma l’insulto più grande è pensare di rubare al signore supremo lo strumento con cui ha creato il mondo: la parola. C’è tutto questo nel mondo della Bruck, ma c’è soprattutto il dramma di un’involontaria ipertrofia allegorica. Sembra che tutto quello che riguardi l’esistenza di un’ebrea nata in Europa nei primi anni del novecento debba necessariamente coincidere con un’iperbole, un’esagerazione, un accanimento eccessivo. Una maledizione. Ogni bambino ha nei primi anni di vita il cosmo nella propria casa, e per i giovani ebrei nati nelle prime decadi del novecento la casa era una capanna di fango e paglia, dove due genitori e tantissimi fratelli condividevano con te l’arcadica (pardon, edenica) consegna delle armi necessarie per affrontare la battaglia della vita: la pertinacia, l’orgoglio, l’unità, la bellezza, la forza. Solo che per i giudei della mitteleuropa quel luogo è un villaggio dove alcuni ti salutano e altri no, senza un motivo. E poi ad un certo punto tutto finisce, devi abbandonare il calore di quel nido prima ancora di aver imparato a volare, e senza aver ancora capito quanto fosse importante, e devi sperderti come ogni adolescente nel bosco del mondo. Solo che per i giudei di quell’epoca, l’abbandono si chiama deportazione nei campi di concentramento della Polonia, di Dacau e di Aushwitz. E poi le sferzate della vita, gli smarrimenti e i bivi da percorrere e le alternative da scegliere per uscire dal bosco e cercare un camminamento adeguato ai propri passi. Solo che per quei giudei, quei bivi sono un indice puntato di un gerarca nazista che può senza motivo decretare la vita o la morte. E poi la giovinezza, e le promesse di un futuro felice, le illusioni e le delusioni di scoprire che è impossibile tornare indietro una volta nati, e che del luogo che una volta si chiamava casa ormai ci sarà rimasto solo un ammasso di detriti e deiezioni derelitte. Ma per i giudei tutto questo è amplificato dalla notizia della terra promessa, della nuova patria in Palestina, dell’obbligo morale di dover aiutare la propria nazione che dopo millenni sta finalmente realizzando la profezia delle profezie.
Ma Israele non è la terra promessa, è solo un luogo dove invece di incontrare persone che ti chiamano ebreo, ci sono persone che ti chiamano ungherese, tedesco, polacco, russo. E ti chiedi se era davvero questo quello per cui con tanta forza hai cercato di mantenerti in vita quando la vita non era neanche tale, ma una continua mortificazione del corpo e dell’animo, fino a farti chiedere cosa ci fosse, davvero, di vivo in te.
E infine la scoperta che non esiste nessun popolo, nessuna terra, nessuna patria, nessun dio ad aspettare i figli di Israele. Ci sono soltanto uomini, e donne. C’è solo lei, la nostra Ditke, e la sua bellezza. Che gira il mondo, che è stanca di menzogne, che è avida di esperienze, che è diventata allergica alle promesse, che non vuole più sentirsi dire come deve vivere, che non vuole più essere complice di nulla. Che ricorda le parole di sua madre, smarrita durante la prigionia dei lavori forzati, mentre i soldati la caricavano a forza nei carri e poi nei treni, in vagoni claustrofobici, ammassati come animali, e che pensava al pane che aveva fatto lievitare durante la notte per poterlo mangiare l’indomani, con tutti i suoi figli, ma che ormai è perduto. E ripeteva ossessivamente, irrazionalmente, meccanicamente, disumanamente che il pane stava ancora lì, che avrebbe dovuto crescere, che era un peccato non poterlo recuperare, che era un peccato commettere un peccato. Ma la mamma, con la sua fede, con le sue parole, con i suoi racconti, con la sua tenerezza, con la sua adesione immotivata, con il suo dio incomprensibile non c’era più. Era smarrita per sempre nel campo di concentramento, e non sarebbe più tornata. La famiglia non sarebbe più rimasta unita. Tutti i fratelli e le sorelle avrebbero fatto di tutto per disperdersi nel mondo, per disaggregarsi, per disintegrarsi nella terra come cenere al vento. Sarebbe rimasta soltanto Ditke, senza più legami, senza più vincoli, senza più pesi a guardare in faccia dio, e arrossire di vergogna pensando alla sua impotenza, oppure al suo cinismo, oppure alla sua distrazione, oppure alla sua cattiveria, o comunque all’impossibilità di conciliare la sua esistenza con il mondo che aveva imposto alla progenie che diceva di amare.
Voto 8
Dispositio
Il racconto è lineare, progressivo, evolutivo e segue le fasi della vita di Ditke dal piccolo villaggio della periferia ungherese nei primi anni trenta fino nelle sue lunghe traversie che l’avevano portata in giro per l’Europa e il medio oriente, e fare finalmente tappa in Italia. In poco più di centoventi pagine vengono condensati ottant’anni di ferite, di colpi, di attacchi subiti da un’esistenza sempre in lotta, e suo malgrado, con tutti. Con i contadini magiari, con i kapò polacchi, con i gerarchi nazisti, con i gentili svizzeri, con i fratelli ungheresi, con i violenti fidanzati e mariti ebrei, con i collerici padroni tedeschi, con i colleghi zingari e cinesi, con gli aristocratici e barbarici romani (non è un ossimoro), con gli ipocriti pudichi napoletani, con i lascivi turchi, con gli ubriaconi russi, con i voluttuosi greci.
La realtà si manifesta con un susseguirsi di scoperte, un continuo sopravvenire di contraccolpi, un insicuro incedere verso il pericolo. Ma è un’epica dell’esistenza, non della realtà quella che a poco a che poco si manifesta nel racconto. Gli inseparabili compagni di viaggio, i veri fratelli, gli unici affetti della protagonista sono i suoi nervi, il suo corpo, la sua forza, l’inossidabile attaccamento alla vita, la fiducia incrollabile nella propria potenza. Come quando, litigando con il marito che vorrebbe strappargli il quadernetto nel quale aveva scritto i suoi primi racconti, lei gli dice che non avrebbe avuto nessuna importanza, e che lo distruggesse pure. Perchè la scrittura è il suo essere, e non il suo fare, e non è possibile sopprimere un’essenza, se rimane in vita un’esistenza. Quello che è nella pagina è quello che si trova nella sua persona. È la sua vita. E lei potrà sempre continuare a scrivere, come potrà sempre continuare a vivere. Contro la violenza dell’irrazionalità, e contro l’irrazionalità della violenza. Ma non è un ragionamento quello che si spiega nelle pagine del testo, non sono grani di saggezza quelli che a poco a poco si aggrovigliano sfogliando le pagine. Sono piuttosto intuizioni ineffabili, percezioni improvvise, rapimenti lampeggianti. Lampi, appunto, e non lumi. Non è importante il mondo, la realtà, la ragione, la parola, la descrizione, la logica. Non contano nulla in questo romanzo. Sono pane perduto. L’unica cosa che conta è l’esistenza, che non si smarrisce mai finché c’è. E come un’esistenza, a poco a poco, lo scorrere delle pagine ci accompagna verso un’inconclusa resa dei conti, con chi quei conti farebbe bene a rendere, oppure a scomparire.
Voto 7,5
Elocutio
La vera avventura di questo romanzo è la sua lingua. Le peripezie, le agnizioni, i colpi di scena, le trovate narrative sono condensate direttamente nella forma, nella sintassi, nella struttura delle perifrasi. Una lingua che non ha paura di unire, di elidere, di fondere, di amalgamare quello che di solito si lascerebbe scisso o intatto. Una prosa fatta di ellissi, certo. E inevitabilmente. Di chirurgiche cesure, e di improvvisi voli verso il dramma. La narrazione diventa immediatamente azione semplicemente con uno zeugma, oppure con una subordinata, oppure con un doppio aggettivo messo prima e dopo il nome. Per far slittare il senso senza perdere mai l’inerzia. Sembra una traduzione da un linguaggio antico, con forme che nell’italiano moderno abbiamo ormai smarrito, o alle quali siamo diventati disavvezzi. Perifrastiche passive, gerundivi, inversioni genitive. Periodi tenuti insieme in una stessa frase avvolti intorno ad una congiunzione che allo stesso tempo li unisce e li separa, li incassa e li monda, li spiana e li infoltisce.
E poi un suffisso, un complemento, un aggettivo che all’improvviso non abbellisce ma illumina, consente di continuare a frugare nel buio di un’anima, di un’epoca, di un’opera. “Eravamo esauste, indifferenti, ma alla vista di un pane intero che una mano aveva gettato dalla finestra, diventavamo delle tigri per strapparne un pezzo e più che in bocca finiva sulla neve, sbriciolato.” La “e” prima della comparazione non unisce, ma introduce, apre il varco verso un nuovo disperante viaggio.
E ancora: “cominciava la semina dei morti, per un colpo di pistola, per un esaurimento delle forze o per malattia, o per un sì o un no dei fattori alla richiesta delle nostre guardie di farci riposare, per una notte, nelle stalle”. Dove il locativo finale ha il sapore di un colpo alle spalle, come quando stai per acquietarti, e stai già quasi assaporando la letizia di un riposo, la tregua di una conclusione, qualunque essa sia, e invece una scudisciata lacerante e ti riporta immediatamente alla realtà; come un dolore che non passa, e che torna all’improvviso a tenerti sveglio mentre vorresti soltanto dimenticarlo.
Una lingua coraggiosa, disincantata, forte, luminescente, avvolgente, che cresce, matura, lievita. Come il mondo, come un mondo feroce creato con le parole da un dio ineffabile. E come il pane.
Voto 8,5
Voto finale: (media degli altri voti con opportuni arrotondamenti) 8,5

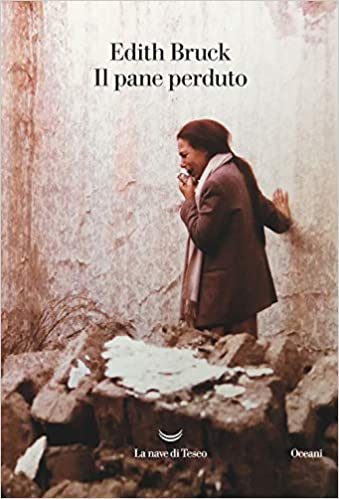





0 commenti