Parlare di un libro che parla di altri libri (che spesso parlano di libri) dà sempre una certa vertigine. Scrivere di uno scritto che parli di scrittura è come fare un viaggio nell’iperspazio, sembra quasi di smarrire il contatto con la terra. Forse perché avere la pretesa di recensire un recensore di recensioni è come muoversi dentro un’iperbole; conviene, quindi, volare bassi.
Occorre dire, però, che questo libro di James Wood (Come funzionano i Romanzi, Minimum Fax, 2021, 275 pagine) è un testo tutt’altro che iperbolico, enfatico, vertiginoso. La sua prosa rapida, ironica, leggera e doviziosa; agevola il viaggio, mette assolutamente a proprio agio il viaggiatore, verso un campo, se non proprio un mondo, spesso trascurato dagli analisti: la forma del romanzo.
Nel proliferare di studi sull’intreccio, la struttura, il contenuto, il nucleo e l’attività romanzesca, qui il taglio è diretto verso lo stile: la tecnica di scrittura, i metodi e i suggerimenti per la resa e l’efficacia del testo.
È un piccolo corso di scrittura creativa, quello che propone l’autore, attraverso le molteplici, variopinte e incredibilmente estese conoscenze letterarie che offre. La cosa più interessante è il fatto che Wood non abbia remore a sporcarsi le mani, entra nel corpo vivo del testo e accompagna le proprie rare ma esaustive categorizzazioni con innumerevoli esempi tratti da brani letterari che riporta con mirabile abbondanza e varietà.
Ancora qualcosa sui suoi capitoli, brevi, chirurgici, essenziali. Sembrano quasi emulare il tempo di lettura media di un editoriale del New York Times, secondo quella celebre battuta del film Il grande freddo. Bè, diciamo che in quello stesso arco di tempo evocato dal film, di capitoli se ne possono leggere anche due o tre.
Sporcarsi le mani. L’autore lo sa, che il vero problema del romanziere non è poi tanto l’intreccio, l’invenzione della fabula, l’impostazione tematica della storia. Lì si può tranquillamente rubare (vedi Shakespeare). Il vero dilemma è rendere l’idea, trasferire con efficacia, eleganza, attitudine, appropriatezza il racconto dalla testa alla carta (anche qui, vedi Shakespeare).
Così, Wood evidenzia alcuni aspetti critici della scrittura dei nostri tempi, ormai assuefatta alle formule e agli stilemi dei secoli passati; anche se molti romanzieri non paiono essersene avveduti.
La vera linea di demarcazione tra il vecchio e il nuovo modo di scrivere ha un nome e cognome ben preciso: Gustave Flaubert.
E la ragione è nella rivoluzione stilistica che il francese ha imposto al mondo, innanzitutto per la cura per il dettaglio visto nella sua natura statica e dinamica. Nelle descrizioni post flaubertiane notiamo che al richiamo dell’elemento statico (un muro macchiato di umido, per esempio) se ne accompagni uno dinamico (una vecchia venditrice che sbadiglia al mio passaggio, tanto per dire) e che la combinazione dei due all’interno del testo renda esplosiva la sua resa espressiva.
Oppure il discorso, riconoscendo come attraverso quello indiretto libero lo scrittore sia in grado di rinunciare alle virgolette, a creare ambiguità inaudita nel lettore, tra l’imputabilità della frase rispetto all’autore o rispetto al personaggio; un’ambiguità che scardina i consolidati presupposti dell’autore omniscente in terza persona e del narratore ignorante in prima “Jean fissava l’orchestra attraverso uno sciocco velo di lacrime” (a chi appartiene l’aggettivo “sciocco”, all’autore o al personaggio?).
O la costruzione del personaggio, mostrando come quello apparentemente “piatto”, cioè privo di adeguate descrizioni preliminari, riesca a rendersi molto più vivido ed empaticamente capace rispetto al classico personaggio “pieno” cui la prosa ottocentesca ci aveva abituato. Sono sufficienti poche, pochissime caratterizzazioni, magari una morale e una estetica, e il nostro può già entrare in scena (“era un gentiluomo con i favoriti rossi che entrava sempre per primo”; è fatta, basta così: azione!)
E ancora, sulla costruzione delle metafore, sulla descrizione degli stati di coscienza, sulla differenza tra la forma e la storia (la prima sarebbe quel che rimane della seconda dopo averla letta); su questi e su tanti altri aspetti l’autore pone in opera una caleidoscopica varietà di esempi, e di metodologie predilette da un saggio esteso di romanzieri. E la cosa interessante è scoprire che tra gli exempla presi in considerazione dal nostro, come massime realizzazioni espressive di testualità romanzesca, oltre ai notissimi russi (Tolstoj e Dostoevskij, Cechov su tutti), francesi (Flaubert, Proust), americani e inglesi (Austen, Woolf, Roth, James), qualche portoghese (Saramago) ci sono anche – sorpresa, sorpresa! – diversi italiani.
Ampie citazioni, o riferimenti, sono tratti da Verga, Svevo, Calvino, Pavese, Primo Levi. E persino, udite udite, Elena Ferrante.
Qui si impone un asterisco. Il libro di Wood è un invito al realismo, alla riabilitazione del realismo rispetto alle tendenze filosofiche e letterarie di verso, apparentemente, opposto. E la Ferrante viene molto apprezzata per le sue rese realistiche, appunto, ma non solo. Anche per aver teorizzato, nella Frantumaglia, la missione della scrittura come “autenticità”, oltre alle classiche categorie della “realtà” e della “verità”. E questa tesi, il nostro autore, sembra gradire molto.
L’autenticità di Elena Ferrante. Fa quasi sorridere: ma come l’autenticità di uno scrittore fantasma? Uno scrittore che si presenta dicendo di non essere quello che è, adesso vorrebbe distribuire patenti di autenticità letteraria, magari un attestato di conformità? Ma voi vi fareste certificare l’azienda da un ente con queste credenziali? Mi tengo stretto il falso, altro che l’autentico; preferisco ascoltare una conferenza di Pinocchio che mi parla di bugie, mi sembra più sincero.
Voglio dire, ci potranno essere tanti modi per apprezzare la Ferrante, ma risulta difficile farlo per un motivo che sembra la negazione ontologica della sua stessa esistenza in vita.
Il realismo, però, resta la vera ossessione letteraria di Wood. E a tal proposito individua un interessante modo di resa, suggerisce un utile strumento di realizzazione del realismo (anche qui, l’iperbole, la tridimensionalità) attraverso il continuo cambio di registro, evidenziato da significative sillogi romanzesche, e illustrando, parola per parola, come (e quando) questi meccanismi riescano a produrre l’effetto desiderato.
Un manuale operativo, da sfogliare, compulsare, controllare, suggere per farsi suggerire.
Con un’unica ossessione: Roland Barthes.
C’è da dire che la tentazione di lanciare il libro contro il muro per chi vi parla è stata fortissima, già dall’introduzione quando, il nostro riportava un’infelice riflessione sul pensatore francese, reo, a suo avviso, di “privilegiare le questioni relative alla forma letteraria rispetto a quelle di carattere politico, storico, etico” (pag.10).
Forse gli sarà sfuggita qualche pagina dei Miti d’oggi, dove il francese aveva lamentato proprio la depoliticizzazione dei contenuti a discapito di una fasulla immagine naturalistica.
Ma il vero problema è l’asserto di Barthes a proposito dell’assenza di referente nella letteratura; il romanzo non parla di niente, il suo linguaggio designa un oggetto inesistente: questo a Wood non riesce a scendergli.
Ogni tanto si lancia in questioni metafisiche sul romanzo che lasciano francamente di stucco, pur riuscendo a non rovinare quanto di buono sia presente nelle parti (e sono le maggiori) non metafisiche del suo lavoro.
La dimostrazione del fatto che l’idiosincrasia verso Barthes avesse qualcosa di patologico la si ritrova nelle note in calce al testo, quando, per cercare di giustificare (più che altro a sé stesso) le affermazioni del filosofo transalpino e tentarne una conciliazione con le proprie, rileva che a suo avviso Barthes sarebbe un cripto platonista (perché assertore dell’arte come imitazione di imitazione, sic!). E quindi, dopo averlo condannato, lo assolve invocano una causa maggiore: “la vera ragione dell’ossessione dei francesi per la fraudolenza del realismo e della narrativa di fantasia in generale ha a che vedere con l’esistenza in francese del preterito, un tempo verbale passato riservato esclusivamente alla scrittura sul passato, e non usato nel parlare. La narrativa francese, in altre parole, ha un proprio apposito linguaggio artificiale, e deve quindi apparire, a certe menti , insopportabilmente letteraria e artificiosa”.
Insomma, alla fine Barthes lo possiamo salvare, aveva delle attenuanti, che il nostro cerca di evidenziare, facendo insieme il ruolo dell’accusa e della difesa. Mitico.
In fondo la sua malcelata incredulità verso le affermazioni Barthesiane appare francamente divertente, nella sua monomaniacalità, che riporta i segni diagnostici della nevrosi (come negazione dell’esistenza di un mondo interiore differente da quello esteriore); insomma Wood non accetta l’idea che il racconto sia un patto finzionale, non vuole ammettere l’evidenza: e cioè che nel romanzo il linguaggio celebri soltanto il linguaggio. Inoltre, non riesce a riconoscere che il genere letterario fiction si chiama in questo modo perché racconta qualcosa di impossibile seppur verosimile (anche se, in questo, dimostra di conoscere benissimo Aristotele).
Ma in ultima analisi, non scende a patti con l’idea di una parola scissa dalla cosa, e considera l’espressione linguistica come un’operazione sempre transitiva. Il realismo è tutto in letteratura. La vera letteratura, la massima manifestazione artistica, la più elevata espressione estetica è quella che riesca ad avvicinarsi alla realtà.
Pur non riuscendo mai ad eguagliarla, s’intende. È una progressione asintotica (e se Barthes era platonico, lui dimostra di essere euclideo). Però la tensione verso la realtà è quello che rende vitale, significativo, e valido (in ultima analisi) un romanzo.
Al punto che ci sorge un dubbio: se dobbiamo scrivere per riprodurre la vita, avvicinare la realtà, realizzare l’esistente…non sarebbe allora meglio smettere completamente di scrivere, e iniziare semplicemente a vivere?

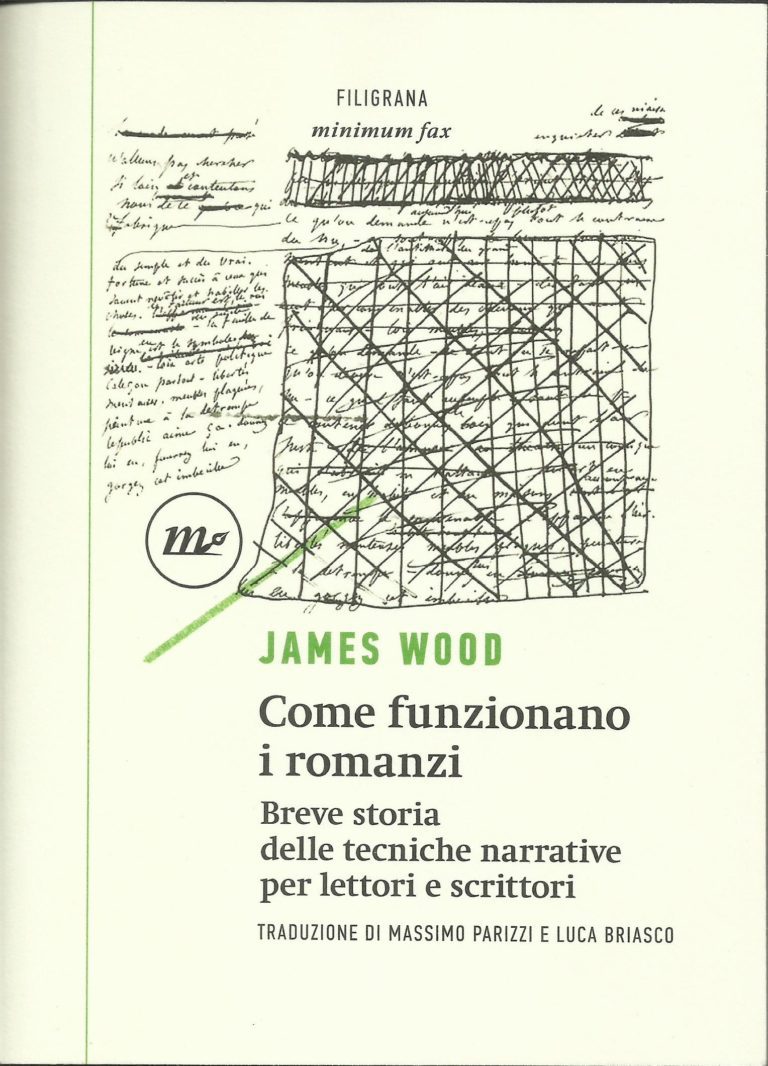





0 commenti